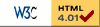Per gli appassionati osservatori Deep Sky dotati di strumentazione adeguata esiste una tipologia di oggetti particolarmente intrigante, quella costituita dai gruppi compatti di galassie, ossia quartetti, quintetti, sestetti e via dicendo. È un tipo di osservazione decisamente meno faticosa ed estenuante di quella che vede coinvolto un intero ammasso di galassie e nello stesso tempo più divertente dell'osservazione di una singola galassia nel campo oculare.
Per gli appassionati osservatori Deep Sky dotati di strumentazione adeguata esiste una tipologia di oggetti particolarmente intrigante, quella costituita dai gruppi compatti di galassie, ossia quartetti, quintetti, sestetti e via dicendo. È un tipo di osservazione decisamente meno faticosa ed estenuante di quella che vede coinvolto un intero ammasso di galassie e nello stesso tempo più divertente dell'osservazione di una singola galassia nel campo oculare.
L'astronomo canadese Paul Hickson dell'Università della Colombia Britannica, 25 anni fa condusse una ricerca sistematica di questi gruppi sulle lastre sensibili al rosso della Palomar Observatory Sky Survey (POSS) e nel 1982 stilò un catalogo di 100 oggetti — noto come HCG — seguendo tre criteri: il primo era quello cosiddetto di popolazione, vale a dire che il gruppo doveva essere costituito da almeno 4 membri; il secondo si riferiva alla compattezza, ossia le galassie dovevano essere comprese in un'area di campo molto limitata; il terzo criterio era quello di isolamento: onde evitare che alcune galassie si trovassero angolarmente vicine per una naturale condensazione all'interno di un ammasso, era necessario che il gruppo fosse...a sé stante, isolato, appunto. Sia chiaro che una catalogazione del genere non era solo fine a se stessa, ma aveva lo scopo preciso di individuare anomalie all'interno dei gruppi, come nel caso emblematico del Quintetto di Stephan, uno dei più famosi (situato nel Pegaso), nel quale la componente NGC 7320 mostrava un redshift nettamente inferiore rispetto alle altre. Lo stesso valeva anche per la galassia NGC 6027D appartenente al celebre Sestetto di Seyfert (situato nellla Testa del Serpente). Queste anomalie possono avere importanti ripercussioni cosmologiche, in quanto è statisticamente abbastanza improbabile che una galassia, dichiarata avulsa dal gruppo in base all'analisi spettroscopica, si trovi ad esso casualmente associata per semplici ragioni prospettiche; o comunque si tratta di un fenomeno piuttosto raro.
Diciamo subito che l'osservazione visuale di alcuni gruppi compatti è relativamente semplice, ma richiede, nella maggior parte dei casi, l'utilizzo di telescopi di almeno 35 o 40 centimetri, un cielo scuro e, soprattutto, un buon seeing per poter ottimizzare gli ingrandimenti. Costituisce un po' il test finale per quei visualisti maturi che desiderano sfruttare a fondo le potenzialità dei loro strumenti.

 Delle 100 voci del Catalogo HCG, che come in tutti i cataloghi procedono per Ascensione Retta crescente, ne prenderemo in considerazione alcuni relativamente semplici per familiarizzarci con questo tipo di osservazione, sebbene le tecniche siano sostanzialmente le stesse utilizzate per altri oggetti come piccole planetarie o insidiose nebulosette che tendono a mascherarsi dietro stelline brillanti.
Un paio di questi gruppi li avrete sicuramente già incontrati: sono i sopramenzionati HCG 92 (Quintetto Stephan) e HCG 79 (Sestetto Seyfert). Il primo è spesso rappresentato sui libri di astronomia o sugli atlanti di galassie in modo vistoso e spesso sgargiante, ma se dobbiamo essere onesti l'osservazione visuale di queste 5 galassiette rimane sempre e comunque una sfida anche in telescopi della classe dei 40 centimetri. C'è chi afferma di averle osservate in telescopi di 15 centimetri! Può darsi (tutto dipende, come sempre, dalla bontà ottica dello strumento, dall'acuità visiva e dalla perizia dell'osservatore), ma personalmente ritengo che con aperture del genere sia possibile al massimo vedere un debole lucore di forma indistinta; per poter osservare comodamente almeno 4 delle 5 componenti — 2 sono di fatto molto vicine — occorrono telescopi di almeno 25 centimetri, forti ingrandimenti e ottiche, possibilmente, pulite; quest'ultimo non è un dettaglio insignificante, perché la polvere depositata sugli specchi, specie se è tanta, diffonde la luce causando una perdita di contrasto dell'immagine che andrà sicuramente a scapito della più debole del gruppo, la NGC 7317. Per separare agevolmente le 2 componenti ravvicinate, NGC 7318 A e B, occorre però uno strumento di circa 40 centimetri (per l'osservazione delle singole galassie inviamo all'apposita sezione DeepSky).
Delle 100 voci del Catalogo HCG, che come in tutti i cataloghi procedono per Ascensione Retta crescente, ne prenderemo in considerazione alcuni relativamente semplici per familiarizzarci con questo tipo di osservazione, sebbene le tecniche siano sostanzialmente le stesse utilizzate per altri oggetti come piccole planetarie o insidiose nebulosette che tendono a mascherarsi dietro stelline brillanti.
Un paio di questi gruppi li avrete sicuramente già incontrati: sono i sopramenzionati HCG 92 (Quintetto Stephan) e HCG 79 (Sestetto Seyfert). Il primo è spesso rappresentato sui libri di astronomia o sugli atlanti di galassie in modo vistoso e spesso sgargiante, ma se dobbiamo essere onesti l'osservazione visuale di queste 5 galassiette rimane sempre e comunque una sfida anche in telescopi della classe dei 40 centimetri. C'è chi afferma di averle osservate in telescopi di 15 centimetri! Può darsi (tutto dipende, come sempre, dalla bontà ottica dello strumento, dall'acuità visiva e dalla perizia dell'osservatore), ma personalmente ritengo che con aperture del genere sia possibile al massimo vedere un debole lucore di forma indistinta; per poter osservare comodamente almeno 4 delle 5 componenti — 2 sono di fatto molto vicine — occorrono telescopi di almeno 25 centimetri, forti ingrandimenti e ottiche, possibilmente, pulite; quest'ultimo non è un dettaglio insignificante, perché la polvere depositata sugli specchi, specie se è tanta, diffonde la luce causando una perdita di contrasto dell'immagine che andrà sicuramente a scapito della più debole del gruppo, la NGC 7317. Per separare agevolmente le 2 componenti ravvicinate, NGC 7318 A e B, occorre però uno strumento di circa 40 centimetri (per l'osservazione delle singole galassie inviamo all'apposita sezione DeepSky).
Uno dei più facili è HCG 44, le cui 4 componenti sono riportate anche sul Tirion; sono situate tra le stelle Zeta e Gamma Leonis e di queste 3 sono osservabili in un modesto 6'': NGC 3185, 3190 e 3193, praticamente allineate lungo la direzione NNE-SSW; l'ultima delle 3 è la più facile del quartetto, mentre per osservare la 3187 occorre un telescopio di almeno 25 cm; rimane tuttavia una galassia debole anche in un 40 cm.

Il Settetto Copland HCG 57, forse meglio noto come Settetto Copland, è sempre stato ritenuto un oggetto fotografico. In effetti le componenti sono tutte molto deboli e richiedono, per una visione agevole, un telescopio di almeno 40 cm. Il gruppo è costituito da 2 terzetti di galassie separati da 3' in direzione NW-SE. Quello più meridionale contiene la più brillante, ossia NGC 3753, allungata da WNW a SSE con dimensioni di 80''x30'' e che presenta un piccolo nucleo di aspetto stellare. NGC 3750 si trova a neppure un primo di distanza verso SW ed è una piccola galassietta compatta che visualmente appare come un nodulo rotondo del diametro di una ventina di secondi. Ancora più difficile ed elusiva è NGC 3754, situata praticamente a ridosso verso NE della componente principale. Del secondo terzetto, invece, la meno difficile è probabilmente NGC 3746; sebbene la fotografia riveli inconfondibilmente la sua natura barrata e la galassia sia circonfusa da un tenue alone elongato da NW a SE, visualmente appare solo come una debolissima chiazza rotonda del diametro inferiore a 1'. Pure molto debole è NGC 3748, situata a poco più di 1.5 verso NE, ma essendo più piccola della precedente e più compatta, si riesce a vedere nonostante abbia una magnitudo integrata maggiore di quasi un punto! Solo di recente sono riuscito a osservare NGC 3745, situata 45'' a nord della 3746, grazie a una nottata osservativa con cielo e trasparenza ottime durante a la quale ho potuto spingere gli ingrandimenti a ben 380x! L'ultima galassietta del Settetto è NGC 3751, la più meridionale. Anche questa è debolissima, e a 188x appare rotonda con diametro di una 30-ina di secondi. HCG 61, situato nella Chioma di Berenice, è un quartetto relativamente facile da osservare con strumentazione modesta ed è costituito da 4 galassie disposte in modo curioso, al punto che gli Americani gli hanno dato il nome di «The Box»; in effetti se si osserva l'immagine pubblicata si nota che sono disposte formando un rettangolo quasi perfetto. Anche per queste preferiamo rimandare all'apposita sezione osservativa.
Se volete visionare il catalogo in formato pdf (248 Kb) potete farlo cliccando qui.